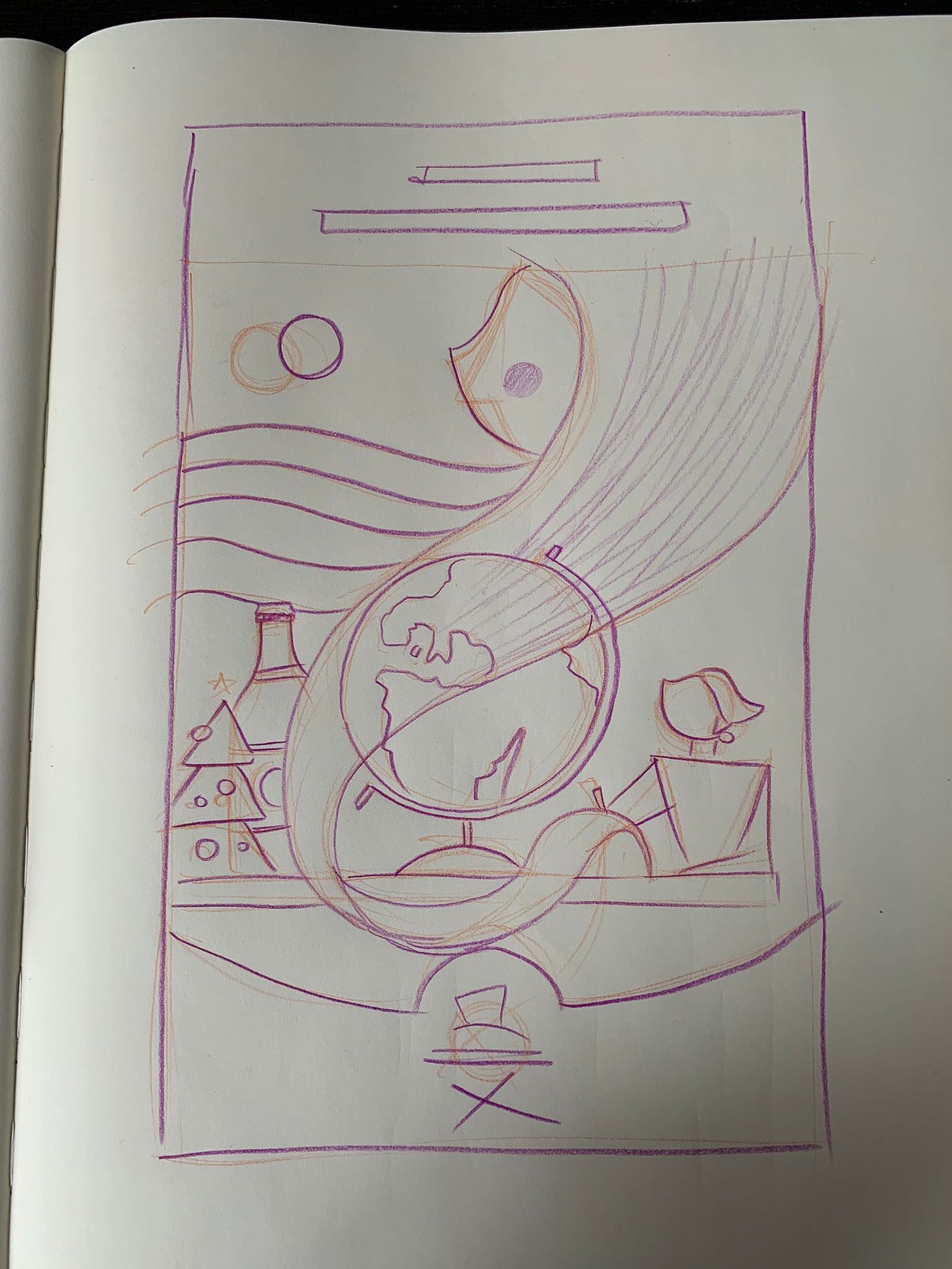Il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene
Quando il conseguimento del talento e dello status di professionista passano per l'attitudine, l'ascolto e il sacrificio. A tutte le età.
Ieri ho tenuto la mia ultima lezione di storytelling per Digital Coach, ho deciso di passare il testimone. E ho scelto anche a chi: Leandra Borsci. Lavora con me a La Content e può serenamente prendere il mio posto. Perché te lo dico? Perché credo che bisogna sapere quando lasciare, o almeno quando cambiare. Quella di ieri è stata una bella lezione, stimolante e, come al solito, sono andato oltre l’orario: dovevamo finire alle 22.30 (è un serale), ma alle 22.45 eravamo ancora lì a guardare progetti. Sento che è arrivata una fase della mia carriera in cui devo fare altro. Non sono stanco – non più di tanto, almeno – e non è nemmeno una questione di stimoli. Credo solo di dover dedicare più tempo alle persone che stanno lavorando per quella che, quattro anni fa, era una mia (nostra) idea e oggi è una azienda.
Già, le persone
Qualche settimana fa ti ho detto che avevo avuto alcune difficoltà a gestirle. C’è chi lo chiama scarto generazionale, ma credo di non avere alcun problema con la Generazione Z. Anzi, trovo coloro che ne fanno parte molto preparati, critici il giusto, veloci. A volte troppo. Amo tutto di loro: mi piace la loro capacità di creare, il valore che danno al tempo, all’ambiente, al benessere, alla salute. Mi piacciono persino i video su TikTok, anche se io non li so fare. Penso, al tempo stesso, che abbiano anche qualcosa da imparare e sono piuttosto sicuro di aver anche capito che cosa sia: pazienza, lungimiranza e talento sono le parole chiave. Poi ci starebbero bene attitudine e sacrificio, ma rischierei di passare per vecchio e non voglio farlo.
Credo di avere tanto da imparare dalla Generazione Z. Lo dico seriamente, mi applico, lo faccio. Mi fa arrabbiare che loro non abbiano altrettanta voglia – non sempre, almeno – di ascoltare noi. La frase “Ok, boomer” – che, per la cronaca, è stata utilizzata per la prima volta dalla deputata neozelandese Chlöe Swarbrick, all’epoca venticinquenne, in risposta a un collega che aveva provato a interromperla durante un suo intervento su una questione ambientale – è molto simpatica, ma ha fatto anche parecchi danni. Viene pensata, usata e pronunciata ogni volta che non siamo d’accordo con un discorso, perlopiù paternalistico o maternalistico1, di una persona più grande di noi. In questo modo, c’è il rischio che vengano a mancare il confronto e la voglia di mettersi in discussione, che tutti noi dovremmo avere.
Il primo ad arrivare, l’ultimo ad andarsene
Nello sport si usa spesso la metafora molto bella del giocatore che è il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene. Spesso e volentieri, si tratta del giocatore più forte. È quello che si ferma a battere le punizioni o i tiri da tre – fai tu –, ad allenarsi sui propri punti deboli e su quelli di forza. A volte convince qualche giovane talento a seguirlo, e spesso gli cambia la vita. Oggi sembra che questa narrazione non vada bene per le aziende. Anzi, che sia diventata tossica. Gran parte della colpa è di quelle che hanno spremuto le persone o, peggio ancora, non hanno riconosciuto alle risorse questi sacrifici.
Personalmente continuerò – come ho sempre fatto – a non chiederli. A far lavorare le persone da dove vogliono e negli orari che desiderano (certo, se lavori la notte e fai l’account, è un problema). A pagarle vista fattura, se sono collaboratori. A garantire loro la possibilità di poter lavorare anche settimane intere dall’estero. Ero così prima della pandemia, figurarsi adesso. E non temo smentita, chiunque potrebbe commentare qui sotto e dire se non è vero.
Ma quello di cui ho bisogno è capire se loro ci credono davvero che essere i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene – non dico tutti i giorni, ma almeno una volta ogni tanto – sia un modo per diventare talenti. Perché se ritengono sia una cosa da perfetti coglioni, allora pensano anche che sia un coglione il loro capo, che di sacrifici – altra parola vietata, mamma mia – ne ha fatti tanti, e ha ancora intenzione di farne. Magari perché amo il mio lavoro o solo perché, se faccio una cosa, la voglio fare sempre meglio. C’è chi la chiama ambizione, chi diversamente. Altrimenti lascio perdere e passo la mano.
Dedicare del tempo a una passione mentre lavoriamo
Lunedì 15 consegnerò all’editore il mio romanzo. Credo che condividere con te che tipo di lavoro è stato sia utile a capire quali sono le difficoltà, le cose da fare, i piccoli consigli che – alla vigilia della consegna – posso trasmetterti. Anche se magari un romanzo non lo scriverai mai.
Scrivere una storia lunga non è facile.
Non è semplice perché tutti noi lavoriamo e nelle vita facciamo altro. Perché il tempo dobbiamo trovarlo nei ritagli – e io nel frattempo due, tre cose buone nel lavoro e nella vita le ho fatte, compreso sposarmi.
Scrivere una storia lunga aiuta a scriverne più brevi: la consapevolezza di poter chiudere un romanzo ti fa sembrare cosa semplicissima le newsletter, i blog post, gli articoli. È allenamento e costanza – ma va? – e io ho avuto dei grandissimi maestri nell’ultimo anno. Non ce l’avrei fatta senza tutti i docenti del corso di Storytelling e Scrittura, senza la severità e la dedizione di Alessandra Minervini, senza la profondità di Chiara Sorrento che si siede accanto a ogni personaggio per analizzarlo e senza la cura di Ettore Zanca che sa come farli muovere, dialogare, parlare.
Che vuol dire tutto questo? Due cose:
1) che i romanzi non si scrivono da soli, ma dobbiamo attorniarci di gente capace, che possa condividere con noi un pezzo di percorso. Vale lo stesso anche per il nostro lavoro;
2) che questa materia si può studiare e non basta leggere. Bisogna mettersi in ascolto di quelli bravi, aprire loro la porta, provare a voler fare qualcosa di simile, anche se bravi come loro non saremo mai.
Avevo un’idea un anno fa, ma un’idea non è nulla.
Soprattutto un’idea non è una storia. Volevo parlare della vigilia di Natale a Bari, ma non avevo i personaggi. Avevo un protagonista e una lunga lettera da scrivere alla figlia. Ma non avevo pensato che lavoro facesse Ernesto, chi fosse sua madre, chi suo padre, chi i suoi amici. Come parlassero, come si muovessero, cosa li caratterizzasse, i colpi di scena, gli oggetti magici, i climax e tutto il resto. Avevo un’idea, ma non avevo uno sviluppo. E un’organizzazione – ti ricorda qualcosa?
Pian piano ho iniziato, con pazienza, a caratterizzarli. Ho eliminato gli spiegoni, ho aggiunto degli hook narrativi, ho lavorato sull’incipit e sul finale come se fossero task – sì, ho detto task – a parte. Ho dedicato due ore al giorno a questa cosa: quando ero ispirato, quando non lo ero, quando sentivo di non potercela fare, quando dentro di me si è annidato il dubbio: “Ma io cosa penso di fare con questa storia?”.
Ho capito che faccio meno fatica in un’agenzia di comunicazione rispetto a stare chiuso in una stanza a scrivere storie e che probabilmente quella dello scrittore non è la vita che farei, ma devo ammettere che mi sento molto orgoglioso di quello che ho fatto.
Alla fine della storia, penso che essere il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene sia ancora una cosa intelligente. E che, se non senti mai questo desiderio, forse non stai facendo un lavoro che ti fa impazzire. Si campa lo stesso – ti do questa buona notizia – ma io una domanda in più me la farei.
Questa è L’ho fatto a Posta, io sono Cristiano Carriero e ti auguro un buon fine settimana, durante il quale, personalmente, non lavorerò!
Sono pronto, come sempre, ad ascoltare i tuoi commenti, le tue critiche e anche qualche Ok, boomer.
P.S. Siamo più di 500 e ne sono molto felice. Non me lo aspettavo in così poco tempo. Se ti va di inoltrare questa newsletter a due amici, mi fa piacere. Se ti è piaciuta, ovviamente.
Meno news, più letter day!
P.P.S. Mi piacerebbe fare una sessione di 40 minuti per discutere con te gli argomenti che ho trattato finora. Che ne dici? Non prendere appuntamenti per mercoledì 1 dicembre alle 18! Ti puoi già iscrivere qui.
A presto!
Non capisco perché si usi “paternalistico” e non “maternalistico”: a me era sempre mia madre a farmi i predicozzi!